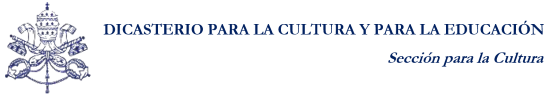«FORTI GRIDA E LACRIME»
Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito.
Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. (Ebrei 5, 7-9)
Anche se tutti gli studiosi (ma l’idea balenava già nell’antichità) concordano ora nell’escludere la paternità paolina a quella splendida omelia (o trattato teologico) che è la Lettera agli Ebrei, si possono tuttavia in essa rintracciare echi riconducibili all’orizzonte di pensiero dell’Apostolo. Nella quinta domenica di Quaresima si propone un intenso frammento testuale di questo “discorso di esortazione”, come lo stesso autore lo definisce. Esso ha al centro la figura del Christus patiens, il Gesù sofferente, pienamente solidale con la nostra umanità: infatti, il soffrire e il morire sono quasi la nostra carta di identità di creature caduche, deboli e misere.
È per questo, come ci ricordano anche gli evangelisti narrando la drammatica preghiera nel Getsemani (vedi, ad esempio, Luca 22, 39-46), che dalle sue labbra escono suppliche accompagnate da «forti grida e lacrime». È l’umanità che reagisce di fronte alla tragedia del dolore più atroce e della morte. Eppure in Cristo si fa strada «il pieno abbandono» al disegno che il Padre sta tracciando nella storia della salvezza e che vede lui come protagonista. Il termine greco usato per indicare questo “abbandono” fiducioso è eulábeia che significa “buona accettazione”, cioè adesione totale.
Dio esaudisce la preghiera del Figlio e lo salva dalla morte non liberandolo dalla morte fisica – che era il segno necessario della fraternità piena di Gesù con l’umanità –, bensì riportandolo alla vita gloriosa nella Pasqua, segno della divinità che non muore. L’autore della Lettera agli Ebrei in pratica commenta la supplica dell’Orto degli Ulivi in cui Gesù invocava: «Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice [del dolore e della morte]! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!» (Matteo 26, 39).
A questo punto nella Lettera si ha una riflessione conclusiva. Come uomo, Cristo è stato «reso perfetto» attraverso l’obbedienza, l’accettazione profonda del volere divino, entrando nella galleria oscura della passione e della morte, divenendo vero uomo in senso pieno, in tutto a noi solidale. Ed è proprio così – in questa vicinanza radicale e totale – che egli può deporre nella nostra fragile e misera umanità il seme del divino, il germe dell’eterno, come sarà testimoniato dalla successiva risurrezione. È con la sua “perfetta” umanità, espressa nella morte, che il Figlio di Dio diventa «causa di salvezza eterna» per tutti coloro che crederanno in lui. Egli, infatti, quando è nella pienezza della sua fraternità umana con noi (e lo è nel dolore e nel morire), non cessa di essere il Figlio di Dio, vivente e glorioso.
Una piccola nota finale. Il verbo del “perfezionamento” dell’umanità di Cristo (in greco teleiotheis) è il termine tecnico anticotestamentario che indicava la consacrazione dei sacerdoti. Ma questa consacrazione di Cristo non avviene attraverso un rito, bensì in una vicenda esistenziale e storica, attraverso la solidarietà piena con l’umanità nel soffrire e nel morire. Non nel rito, ma nella vita.