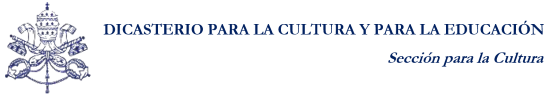«Chi oserà dire: Io credo in Dio? Puoi domandare a preti o a saggi e la risposta sembrerà prendere in giro chi ha fatto la domanda». C’è, dunque, una sorta di corto circuito, secondo il Faust di Goethe, ogni volta che si comincia a professare il Credo, e questa tensione nasce dalla dimensione trascendente insita alla fede: essa sembra estenuare ogni risposta, rendendola sospetta o imperfetta. Eppure il rischio di procedere su quel sentiero fatto di domande deve essere corso, come aveva fatto Abramo, “nostro padre nella fede”, che era salito lungo le erte e irte pendici del monte Moria, stringendo con una mano la spalla del suo ragazzo Isacco e nell’altra impugnando la risposta oracolare divina, paradossale se non assurda: essa, infatti, gli imponeva di sacrificare quel figlio, smentendo così lo stesso Dio che quel frutto delle sue viscere glielo aveva prima promesso e poi donato, come si narra nel cap. 22 della Genesi.
Aveva, allora, ragione Kierkegaard quando – commentando proprio questa scena biblica in Timore e tremore – aveva concluso: «La fede è la più alta passione d’ogni uomo. Ci sono forse in ogni generazione molti uomini che non arrivano fino ad essa, ma nessuno va oltre… La fede comincia appunto dove la ragione finisce». È facile a questo punto lasciarsi trascinare in un discorso che da secoli l’umanità affronta senza mai esaurirlo, tant’è vero che esso ha riacquistato vigore persino in questi nostri tempi così depressi, superficiali e restii a imboccare i percorsi d’altura. Abbiamo voluto proporre questa premessa generale, partendo dalla citazione che Faust fa dell’incipit della professione di fede cristiana, non per presentare un saggio teologico o filosofico sul credere, bensì per segnalare un testo curioso che ha cercato di collezionare nell’arte cristiana italiana una sorta di esegesi al Credo che ogni domenica è proclamato in tutte le chiese del mondo.
Bisogna anche ricordare a margine che, sempre in questi mesi, FMR e Art’è hanno allestito un monumentale e sontuoso libro-oggetto, destinato al manipolo dei bibliofili opulenti, proprio per illustrare il Credo, attraverso Immagini d’arte e di letteratura, come recita il sottotitolo. Ma ritorniamo al nostro più maneggevole e immediato saggio di Roberto Mastacchi che nel 2004 aveva già pubblicato uno scritto dedicato al tema ma da un’altra angolatura (I Padri spiegano il Credo). Ora è di scena l’arte in tutte le sue espressioni, dalla pittura alla scultura, dagli arazzi ai legni intagliati o intarsiati: essa cerca di “visualizzare” e quindi di “narrare” e illustrare i vari articoli di fede, cogliendo gli snodi fondamentali che scandiscono quel testo liturgico, soprattutto nella sua formulazione più classica e comune, ossia il cosiddetto “Simbolo apostolico”.
Si parte, così, da “Dio Padre onnipotente creatore”, si procede verso il “solo Signore Gesù Cristo” salvatore e verso lo Spirito Santo, per approdare alla Chiesa e all’escatologia. A livello iconografico è suggestiva la tipologia della “scrittura” del formulario stesso del Credo: apostoli o santi reggono libri aperti o cartigli recanti i vari segmenti testuali della professione di fede. C’è, però, anche la rappresentazione scenica che ricrea figurativamente i versetti del Credo. Un’oasi particolare per celebrare questa esaltazione della fede è naturalmente una città di nobilissime tradizioni artistiche come Siena alla quale è riservato un capitolo specifico. Si intuisce, così, come fosse vero quanto dichiaravano nei loro Statuti d’arte i pittori senesi del Trecento: «Noi siamo manifestatori agli uomini che non sanno lettura, delle cose miracolose operate per virtù della fede». L’arte si trasformava in catechesi, rivelando l’intreccio profondo che la univa alla fede. Anzi, un grande cultore della teologia dell’arte come il Padre della Chiesa d’Oriente Giovanni Damasceno (VII-VIII sec.) andava oltre, intuendo nell’espressione artistica la via privilegiata per il dialogo con chi non crede o crede diversamente: «Se un pagano viene e ti dice: Mostrami la tua fede! tu portalo in Chiesa e mostra a lui la decorazione di cui è ornata e spiegagli la serie dei sacri quadri».
In questa luce l’opera di Mastacchi, pur col suo rigore critico attestato anche dalle schede dell’appendice iconografica, si trasforma in una riconferma di quel fecondo connubio tra arte e fede che aveva fatto confessare a Marc Chagall: «I pittori per secoli hanno intinto il loro pennello in quell’alfabeto colorato della fede che era la Bibbia». Liturgia, fede, arte erano allora sorelle, senza imbarazzi e senza prevaricazioni, in un’armonia che ha generato per secoli capolavori di bellezza e di spiritualità.
Roberto Mastacchi, «Il Credo nell’arte cristiana italiana», Cantagalli, Siena, pagg. 206.