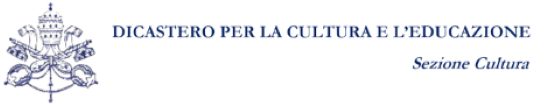CAPIRE E SOFFRIRE
Grande sapienza è grande tormento. Chi più sa, più soffre. (Qohelet 1,13)
«A tanta gente occorre un certo numero di luoghi comuni da ripetersi scambievolmente come pappagalli, coi movimenti affettati, gli impettimenti e le strizzatine d’occhio di quell’uccello. Ma non si possono nutrire i pappagalli col vino aromatico del libro di Giobbe o dell’Ecclesiate/Qohelet». Aveva ragione lo scrittore cattolico francese Georges Bernanos quando, nel 1938, nell’opera I grandi cimiteri sotto la luna, univa i due sapienti biblici nel disprezzo per la dilagante banalità, il vuoto interiore che attanaglia la coscienza dell’uomo contemporaneo.
Dal libretto fatto di 2987 parole ebraiche, distribuite in 222 versetti, che il Qohelet – uno pseudonimo ebraico che, più o meno, significa “presidente dell’assemblea” – ci ha lasciato, abbiamo estratto una frase brevissima, ma fortissima, dal sapore autobiografico. Essa paradossalmente riconosce un vantaggio allo stupido, quello dell’essere ilare nella sua beceraggine. La persona intelligente, infatti, vede l’inconsistenza che corrode l’essere, sente ramificarsi la mano gelida della morte che pervade ogni atto che si compie sotto il sole e non può rimanere indifferente e serena.
Nella sua dichiarazione amara, per definire la sofferenza del sapiente, Qohelet usa il vocabolo ebraico ka‛as che indica il cruccio, il tormento, il peso sul cuore, ma anche l’oppressione fisica, il tutto associato a una sorta di indignazione. Un rabbino medievale, Saadià Gaon, acutamente commentava: «La scienza svelava a Qohelet il vizio che si annida nelle cose», cioè quella sorta di tarlo segreto che intacca l’essere e che il sapiente biblico chiama con un termine famoso, havel, cioè “vanità, vuoto, fumo”, un termine che egli usa al superlativo ebraico, havel havalîm (1, 2; 12, 8), divenuto il celebre vanitas vanitatum della versione latina, ossia il vuoto supremo che consuma l’essere e l’esistere, spezzando e spazzando via ogni illusione.
Per ben 38 volte risuona nelle pagine di Qohelet questa parola aspra ed egli non ci risparmia nessuna occasione per gettarci in faccia la nostra sostanziale miseria, anche se noi giriamo il viso da un’altra parte. Nella storia, nelle esperienze personali, nel mondo, nella società, nel nostro stesso corpo si diffonde questo havel, che incrina il piacere, devasta la pace, inquieta lo spirito. Per questo, come si diceva, lo stupido continua a chiacchierare soddisfatto ed evita accuratamente di scavare sotto la superficie della sua esistenza banale. È ancora per questo che, come diceva Bernanos, non si può destinare Qohelet ai pappagalli che ripetono ininterrottamente i loro scherzetti.
Se vogliamo, invece, cercare di capire, anche per reagire ed essere consapevoli, prendiamo in mano questo libro intelligente. Certo, come osservava un suo commentatore moderno, «dalla sua lettura non si esce indenni, ma adulti o pronti a diventarlo». È un rischio da correre, se si vuole essere autenticamente persone che sanno, che giudicano e che lottano, e non individui vani e vacui.