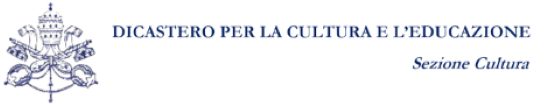CISTERNE PIENE DI CREPE
Il mio popolo ha abbandonato me, sorgente di acqua viva, e si è scavato cisterne piene di crepe che non trattengono l’acqua. (Geremia 2,13)
Un’arida distesa stepposa e, laggiù, in fondo un’oasi verdeggiante o un pozzo a cui accorrono i pastori coi loro greggi. È questa una scena tipica del mondo biblico. Al centro c’è, dunque, o la sorgente o il pozzo d’acqua gorgogliante, fonte di vita, tant’è vero che il libro dei Numeri ci ha conservato un antico canto degli scavatori dei pozzi: «Sgorga, o pozzo: cantatelo! Pozzo scavato da principi, perforato da nobili del popolo, con lo scettro o coi loro bastoni!» (21,17-18). Come accade nella posa delle prime pietre dei palazzi, così i capi di Israele coi loro scettri, segni di potere, davano il primo colpo al terreno da scavare per risalire alla vena d’acqua.
Spesso, però, ci si doveva affidare alla pioggia e l’oro bianco dell’acqua era custodito nelle riserve idriche, le cisterne, preziose in tempo di siccità. In una pagina di straordinaria fragranza poetica, il profeta Geremia descrive un’annata totalmente secca e la sconsolata reazione di fronte a cisterne vuote: «I nobili mandano i servi in cerca d’acqua; si recano ai pozzi ma non ne trovano e tornano con recipienti vuoti: sono pieni di delusione, di confusione, si coprono il capo» in segno di lutto (14,3).
Ebbene, è questo stesso profeta a ricorrere al simbolo di una cisterna per una lezione sulla fede nel vero Dio, «sorgente di vita» (Salmo 36,10). Egli conduce il suo ascoltatore davanti a una delle tante cisterne allora in funzione nelle città e nei villaggi. L’archeologia ne ha messe in luce molte, con le pareti impermeabilizzate attraverso intonaco, oppure ricavate in cavità naturali che, con le loro pareti calcaree porose e con la selce che le costituiva, divenivano una sorta di grande anfora naturale. Non mancavano cisterne con gradini per l’accesso ai successivi livelli decrescenti dell’acqua: celebre quella del X secolo a. C. scoperta a Gabaon, profonda 10 metri, larga 11, capace di 180.000 litri d’acqua e dotata di una scala di 40 gradini.
Geremia, però, ben sapeva che esistevano cisterne screpolate, incapaci di conservare quel bene prezioso e destinate alla fine a trasformarsi in fondi fangosi. Lo sapeva per esperienza personale, sottoposto com’era stato a ogni genere di vessazioni dal potere di allora. Una volta, infatti, era stato incarcerato nella cisterna del palazzo del principe Malkia: «Ve lo calarono con corde; nella cisterna non c’era acqua ma fango e così Geremia affondò nella melma» (38,6). Facile, allora, è il messaggio che egli vuole lasciare a tutti noi.
Esso è formulato proprio attraverso il confronto incisivo tra una fonte d’acqua viva e una cisterna con crepe che trattiene solo umidità e fango. Dio e l’idolo, la fede e la superstizione, la vita e l’illusione, la virtù e il vizio si confrontano tra loro. E la conclusione è amara: l’umanità ama la melma in cui sguazzare rispetto alla limpidità dell’acqua fresca e corrente. Il pensiero va spontaneamente a una scena parallela, anche se un po’ differente, ma dall’esito spirituale analogo. Ce la propone il Vangelo di Giovanni.
Gesù è seduto sul parapetto di un pozzo, detto di Giacobbe, nei pressi della città di Sicar in Samaria, e alla donna che è venuta ad attingere acqua non esita a dichiarare: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna» (4,13-14).