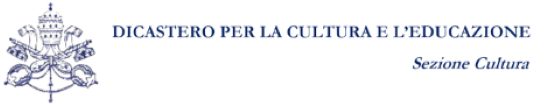RENDERE RAGIONE DELLA SPERANZA
Siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Ma questo sia fatto con dolcezza, rispetto e retta coscienza. (1 Pietro 3,15-17)
Abbiamo aperto uno scritto del Nuovo Testamento steso in un greco molto raffinato (ci sono 62 parole greche che non ricorrono nel resto delle pagine neotestamentarie). Il titolo non ha esitazione nell’attribuire questa Lettera, la prima delle due, a Pietro, «apostolo di Gesù Cristo», il quale scrive però per mezzo di un segretario, Silvano (5,12), forse quel Sila che negli Atti degli Apostoli è anche collaboratore di san Paolo. La Lettera è composta a Roma, menzionata con l’epiteto usato dagli scritti apocalittici giudaici e cristiani, “Babilonia”. Molti studiosi pensano che l’opera sia da riferire alla tradizione petrina più che all’Apostolo in modo diretto, perché sembra rivolgersi alla seconda generazione dei cristiani: «Voi amate Cristo senza averlo visto e senza vederlo credete in lui» (1,8).
Il testo è, comunque, una splendida testimonianza della vita ecclesiale delle origini cristiane, in particolare dell’esperienza battesimale. Un’esistenza vissuta nel cuore dell’impero romano, nella consapevolezza di essere «una fraternità sparsa nel mondo» (5,9). Acquista un significato particolare, allora, il frammento – per altro molto noto – posto al centro della nostra riflessione. Per illustrarlo in modo più netto dobbiamo ricorrere a un’immagine cara a questa Lettera, quella della “casa”, in greco oikos.
Con essa si raffigura la Chiesa che è una «casa spirituale», edificata sulla fondazione di Cristo, «pietra viva», e con le pareti fatte di «pietre vive» che sono i cristiani, una casa che è in realtà un tempio perché in essa si offrono «sacrifici spirituali» (2, 4-5). La Chiesa, però, continua Pietro, è anche paroikía (vocabolo greco dal quale è derivato il nostro termine “parrocchia”), cioè “fuori casa”, in pellegrinaggio verso un’altra casa, una meta superiore (1,17; 2,11). Questo cammino si svolge appunto nelle strade del mondo ove s’aggirano forze ostili, «l’avversario, il diavolo, simile a un leone ruggente in cerca della preda da divorare» (5,8).
Ci si imbatte nell’«incendio della persecuzione, acceso per mettere alla prova» (4,12), si è oltraggiati, contestati, tentati di nascondersi, mentre è necessario che, se uno soffre come cristiano, non si vergogni ma glorifichi Dio per questo nome» (4,16). In questa atmosfera, mentre si è in paroikía, cioè lungo le vie della storia, è importante il monito che è presente nel nostro versetto. Il cristiano deve conservare intatta la fiducia e la serenità, tenendo alta la fiaccola della speranza.
A chi lo interroga chiedendo le ragioni di questa fiducia e della sua visione del mondo e della vicenda umana, il fedele risponde «con dolcezza, rispetto e retta coscienza», senza aggressività, reagendo pacatamente anche alle accuse, ma sapendo illustrare con efficacia e con motivazioni la sua scelta di fede e di vita. È, questo, un luminoso programma di testimonianza, un esempio di certezza, ma è anche un modello di dialogo, di coscienza limpida della propria identità cristiana, senza però integralismo e chiusura.