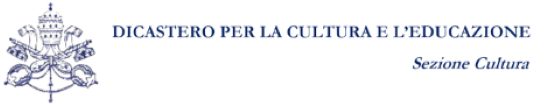SHELETRI INARIDITI
Profetizza su queste ossa: Ossa inaridite, udite la parola del Signore! Io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete! Stenderò su di voi i nervi, farò crescere la carne, su di voi allargherò la pelle… (Ezechiele 37,4-6)
Ritto, davanti a un’immensa pianura. Lo sguardo è fisso, atterrito: ciò che si distende su quella superficie è una coltre sterminata di scheletri calcificati. Quell’uomo, l’unico vivo in una valle di morti, è il profeta Ezechiele (VI secolo a. C.) e questa è una delle indimenticabili e surreali visioni che egli ha “dipinto” nelle sue pagine. Ecco, all’improvviso, un ordine a prima vista assurdo. Il profeta dovrà predicare a quella massa di ossa aride. E il messaggio è, in realtà, un comando ancor più assurdo: Rivivete, tornate ad essere creature vive, in carne, ossa, nervi, arterie, pelle…!
L’impossibile si compie: soffia, infatti, il respiro dello Spirito divino creatore, invocato da Ezechiele, ed ecco «uno scricchiolio, un formicolare tra le ossa che s’accostavano ciascuno all’osso corrispondente; ecco tendersi i nervi, la carne crescere, la pelle coprirla». Manca ancora il fiato vitale: sarà lo Spirito a passare su quegli organismi ancora inerti, ed «essi ritornarono in vita, si alzarono in piedi: erano un esercito grande e sterminato» (37,7-10).
Il profeta, proprio con questa frase finale, voleva, attraverso la scena impressionante appena evocata, raffigurare la sperata rinascita di Israele che allora era come morto nell’esilio e nella schiavitù «lungo i fiumi di Babilonia», ove era stato deportato dopo la distruzione di Gerusalemme del 586 a. C., ordinata da Nabucodonosor. Ma la tradizione successiva ha trasfigurato questa pagina nella celebrazione della risurrezione finale.
È questo già il senso della sua prima rappresentazione pittorica nella sinagoga (o chiesa giudeo-cristiana) di Dura Europos in Siria, nel III secolo (ora nel Museo di Damasco). Lo è nell’arte cristiana, come accade ad esempio negli affreschi di Luca Signorelli nella cappella di san Brizio del Duomo di Orvieto. Ha acquistato questa tonalità anche nella musica, come nel caso dell’opera De visione resurrectionis di Walter Jacob o nel Libro d’organo di Olivier Messiaen. Una scena, quindi, che sa intrecciare arte e teologia.
Sì, perché alla base di questo possente quadro poetico c’è, comunque, la certezza che «il Creatore del mondo, il quale ha plasmato alla sua origine l’uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua misericordia può restituire di nuovo lo spirito e la vita», come dice la madre dei sette fratelli morti martiri durante la persecuzione siro-ellenistica del II secolo a. C. (2 Maccabei 7, 23). La risurrezione è, pertanto, una nuova creazione: le ossa aride sono come la polvere del suolo e lo spirito che soffia è lo stesso principio vitale che Dio pone nella creatura, come si racconta nel libro della Genesi (2,7). Cantava Isaia: «Di nuovo vivranno i tuoi morti, i cadaveri risorgeranno! Svegliatevi ed esultate voi che giacete nella polvere. La tua rugiada, o Signore, è rugiada luminosa: la terra darà alla luce le ombre!» (26,19).