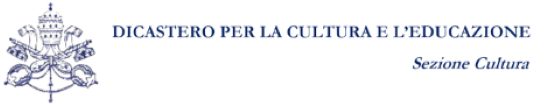«Tra religione e scienza non esistono né parentele né amicizia ma neppure inimicizia: vivono in sfere diverse». Era il 1878 quando Nietzsche scriveva queste parole, anticipando di oltre un secolo lo scienziato Stephen Gould e la sua teoria dei «magisteri non sovrapponibili» di scienza e teologia. In realtà, l’unitarietà dell’oggetto esaminato, cioè l’essere e l’esistere con la loro polimorfia, ma anche la coscienza unificante del soggetto, ossia la persona che ha in sé più canali di conoscenza (razionale, sensoriale, estetico, etico, filosofico, teologico), fanno sì che un’interlocuzione tra l’approccio scientifico e quello teologico (ma non solo) sia legittima, pur nel rispetto dei diversi statuti epistemologici.
Questa premessa permette la segnalazione di due saggi che s’inerpicano proprio sui percorsi d’altura del dialogo tra scienza e fede. Anzi, i loro autori si sono dedicati, senza prevenzioni, anche ad affacciarsi oltre la frontiera del credere nella regione dei cieli vuoti di divinità, ove s’attestano i cosiddetti non credenti. Il primo è Francesco Brancato, un teologo dai molti interessi, anche letterari, in dialogo costante con la cultura contemporanea, rivelando una competenza sempre qualificata e penetrante. Il sottotitolo – «Tra creazione ed evoluzione» – svela l’orizzonte della sua nuova opera, ampia e architettata secondo navate ideali che ospitano i due termini citati secondo uno specifico angolo di visuale.
Lo spunto è offerto da un anniversario passato in sordina, i 150 anni nel 2021 della pubblicazione dell’Origine dell’uomo e la selezione sessuale di Charles Darwin, meno nota del più celebre Le origini della specie (1859). A patrocinare lo studio del teologo siciliano è uno dei patriarchi dell’antropologia culturale in Italia, Fiorenzo Facchini, emerito dell’università di Bologna che ha allungato la lista dei sacerdoti uomini di scienza (Copernico, Stenone, Mendel, Mercalli, Stoppani, Lemaitre, Heller etc.). Semplificando, possiamo dire che in quel saggio Darwin applicava alla specie umana la sua tesi generale evoluzionista: l’uomo deriva da specie antecedenti inferiori attraverso una serie di modificazioni evolutive che generano appunto l’ominizzazione.
È da ribadire che lo scienziato inglese non volle mai inoltrarsi nel terreno scivoloso della metafisica riferendosi alla creazione divina o all’anima, impedendo così alla sua teoria biologica di tramutarsi in tesi filosofica, come farà invece uno dei suoi discepoli, il tedesco Ernst H. Haeckel, alfiere del monismo materialistico dinamico-evolutivo e antesignano di un certo neodarwinismo totalizzante. Brancato, in un itinerario molto ramificato e avvincente si attesta proprio sul suo versante specifico, quello teologico, dopo aver perlustrato e visitato l’altro orizzonte da ospite, senza lasciarsi tentare dall’emettere sentenze critiche che non gli competono o infilare la via artificiosa del concordismo.
È solo dopo quella visita (leggi «conoscenza»), che egli propone la sua articolata riflessione sull’evoluzione alla luce della creazione, ricorrendo a figure fondamentali del Gotha teologico come Rahner, Pannenberg, Moltmann e soprattutto Ratzinger, recuperando anche quel Teilhard de Chardin che aveva fatto balenare un asse cristologico al teologo desideroso di interpretare la realtà antropologica nella sua evoluzione. Un confronto forse non sempre condotto dallo scienziato gesuita sul crinale della distinzione dei due campi, ma sicuramente fecondo. E alla «conoscenza scientifica e credenza religiosa in dialogo» – ancora secondo il suo sottotitolo – è riservato il libro del filosofo Roberto Timossi che, però, pone il suo volume all’insegna di un titolo giudicato da lui stesso «originale, oppure sconcertante, eccessivo e azzardato, se non apertamente provocatorio»: La fede salverà la scienza.
Noi lo consideriamo semplicemente brutto, se non equivoco, col rischio che illuda i fondamentalisti, destinati poi a trovarsi a disagio leggendo il testo, e allontani chi invece vuole approfondire quel dialogo segnalato dal sottotitolo, i veri destinatari dell’opera. La trama è, infatti, didattica nel senso alto del termine, come è accaduto per vari altri libri di Timossi che puntavano alla ragionevolezza della fede anche nel mondo contemporaneo e che vagliavano con acutezza il fenomeno dell’ateismo. Nella ricomposizione del quadro storico dell’interazione tra fede e scienza un capitolo è ovviamente riservato anche al tema dell’evoluzione, ma lo sguardo è veramente panoramico, ed è per questo che il volume si trasforma in una sorta di mappa del tema generale.
Seguirne i tracciati è veramente un’esperienza godibile, sia per il rigore con cui vengono delineati (anche quando si tratta di percorsi deviati, ossia gli «errori incrociati» della scienza e della teologia), sia per la limpidità delle analisi che partono da un profilo del credere stesso e del suo sapere. Si scandiscono, poi, tutte le tappe in cui si è coniugato quel rapporto, soprattutto nei suoi snodi cruciali antropologici e cosmologici. E alla fine, nel capitolo che delinea un’applicazione nelle coordinate storiche presenti – marcate soprattutto dalla Laudato si’ (egli usa erroneamente il titolo papale Francesco I) – ritorna il modulo del titolo, ma più compostamente definito come un «salvarsi a vicenda» tra scienza e fede.
GIANFRANCO RAVASI
Francesco Brancato, L’uomo e la sua origine, Mimesis, pagg. 315, € 26,00.
Roberto Giovanni Timossi, La fede salverà la scienza, San Paolo, pagg. 299, € 22,00.