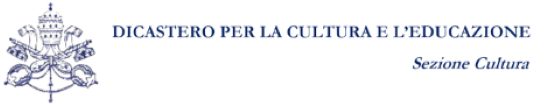«E proprio qui, ai piedi di questa stupenda policromia sistina, / si riuniscono i cardinali – / una comunità responsabile per il lascito della chiavi del Regno… / La policromia sistina allora propagherà la Parola del Signore: / Tu es Petrus – udì Simone, il figlio di Giona. / “A te consegnerò le chiavi del Regno…” / Era così nell’agosto e poi nell’ottobre / del memorabile anno dei due conclavi, / e così sarà ancora quando se ne presenterà l’esigenza / dopo la mia morte». Era il 2002 e Giovanni Paolo II, già segnato dalla malattia, pubblicava il suo ultimo testo poetico, il Trittico romano che aveva al centro l’affascinante “policromia sistina”.
Sotto quelle volte affrescate da Michelangelo cinquecento anni fa, davanti all’emozionante “Giudizio Finale” che l’artista avrebbe condotto a termine trent’anni dopo, si compiva nel 1978 la straordinaria esperienza dei due conclavi che avrebbero eletto pontefici prima il patriarca di Venezia, il cardinale Albino Luciani col nome di Giovanni Paolo I il 26 agosto 1978, e poi l’arcivescovo di Cracovia Karol Wojtyła il 16 ottobre 1978 come Giovanni Paolo II. In quei versi egli faceva balenare già il futuro («così sarà… dopo la mia morte»), compiutosi il 19 aprile 2005 con l’elezione di Benedetto XVI. E ora, a distanza di quasi otto anni – in un contesto del tutto inedito (tranne rare e remote eccezioni, come quella di Celestino V nel 1294, già presentata in queste pagine) a causa della rinuncia del predecessore – un nuovo papa verrà eletto in quella stessa Cappella che sulla parete destra reca la simbolica scena evangelica della “consegna delle chiavi” a Pietro, dipinta dal Perugino.
È ciò che avviene attraverso il cosiddetto “conclave”, un termine evidentemente legato all’isolamento in cui i cardinali elettori conducono quell’atto capitale della vita e della storia della Chiesa cattolica, rinchiusi “a chiave” nello spazio sacro della Cappella Sistina. L’elezione del Romano Pontefice, detto “papa” con un vocabolo greco (papas) che semplicemente significa “padre”, è disciplinata da un testo ufficiale promulgato da Giovanni Paolo II il 22 febbraio 1996. È la costituzione apostolica Universi Dominici Gregis il cui cuore era, comunque, già recepito nel canone 332 § 1 del Codice di Diritto Canonico del 1983: «Il Romano Pontefice ottiene la potestà piena e suprema nella Chiesa con l’elezione legittima, da lui accettata, insieme con la consacrazione episcopale. Di conseguenza l’eletto al sommo pontificato che sia già insignito del carattere episcopale ottiene tale potestà dal momento dell’accettazione. Che se l’eletto fosse privo del carattere episcopale, sia immediatamente ordinato Vescovo».
Questa puntualizzazione sul carattere episcopale o meno dell’eletto – ovviamente necessario per esercitare l’ufficio di Vescovo di Roma, sostanziale per essere papa – rivela che il raggio degli eleggibili è molto vasto e di per sé va oltre il Collegio cardinalizio. In passato, per secoli, l’elezione del pontefice cadeva spesso su un semplice prete e persino su un diacono. Curioso fu il caso di Adriano V, Ottobono di Teodisco Fieschi dei conti di Lavagna, che fu eletto l’11 luglio 1276 mentre era diacono, si ammalò ben presto e morì il 16 agosto successivo, senza essere consacrato prete e vescovo (Dante lo collocherà nel Purgatorio XIX, 88-145, nel cerchio degli avari). Tuttavia, egli rimane nella serie dei Sommi Pontefici proprio perché si riteneva che avesse già la giurisdizione dal momento dell’accettazione, prima ancora dell’ordinazione episcopale che – come si nota nel canone citato – deve comunque essere “immediatamente” (statim in latino) compiuta.
Le riunioni del conclave obbediscono a regole stabilite, oltre che dalle norme generali della citata Universi Dominici Gregis, anche da un Ordo rituum Conclavis, emanato nel 1998. L’11 giugno 2007 Benedetto XVI con un “motu proprio” ha prescritto per le votazioni che, anche nel caso di ballottaggio, la maggioranza richiesta per l’elezione del papa sia sempre, in ogni scrutinio, quella qualificata dei due terzi dei suffragi. In questo caso, però, i due candidati del ballottaggio sono privi di voce attiva. Sui tempi di indizione del conclave – come ormai è noto – ulteriori indicazioni concrete sono state offerte nei giorni scorsi dal nuovo “motu proprio” Normas nonnullas emesso da Benedetto XVI con la data del 22 febbraio. Ma su questa prassi e sulle sue regole si è già scritto molto sui giornali. Noi, invece, vorremmo ora risalire a un tema di base, ossia alla radice stessa del papato e al suo vincolo con la figura del “principe degli apostoli”.
Il legame di Pietro, il primo dei papi, con Roma – come si è avuta occasione di dibattere su queste stesse pagine – è ben fondato a livello storiografico ed è su questo tema che ora offriremo qualche spunto essenziale, procedendo per gradi. Il punto di partenza è in un brano allusivo che suggella il Vangelo di Giovanni. In esso, Gesù annunzia il destino futuro a Pietro, appena investito del ministero di «pascere gli agnelli/pecorelle» del gregge di Cristo: «Quando sarai vecchio, tenderai le tue mani e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi» (21,18). L’espressione «tendere le mani» sembra alludere alla prassi della crocifissione che era, tra l’altro, preceduta anche dal fatto che il condannato portava l’asse trasversale della croce con le mani legate ad esso, prima che vi fossero inchiodate una volta giunto sul luogo del supplizio.
Comunque sia, sta di fatto che alla frase segue un commento esplicito dell’evangelista che attesta un dato noto ai suoi lettori: «Questo gli disse per indicare con quale morte [Pietro] avrebbe glorificato Dio» (21, 19). Frase analoga a quella che Giovanni aveva già usato per la stessa morte in croce di Gesù (12, 32-33). Pietro, quindi, morì martire e lo stesso appello finale di Cristo – «Tu seguimi» – conferma che il discepolo doveva portare la sua croce sulla via della donazione sacrificale secondo il famoso monito: «Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me» (Matteo 10, 38). A questo punto dobbiamo passare a un’altra tappa che cerca di rispondere alla domanda sull’ambito spaziale dove la vicenda umana di Pietro si è conclusa.
Sappiamo che negli Atti degli apostoli Luca, dopo aver descritto nel c. 15 il “concilio” di Gerusalemme, abbandona la figura di Pietro e punta la sua attenzione esclusivamente su Paolo che segue fino a Roma. Ora, è interessante notare che la Prima Lettera di Pietro contiene una particolare indicazione finale: «Vi saluta la comunità che è stata eletta come voi e che dimora in Babilonia» (5,13). È noto, anche attraverso l’Apocalisse, che “Babilonia” era spesso il simbolo usato per indicare la Roma imperiale. «Pietro, apostolo di Gesù Cristo» che scrive questa Lettera ai cristiani dell’Asia minore (1,1) si troverebbe, dunque, nella capitale. Quand’anche – come vuole qualche studioso – lo scritto fosse opera di un discepolo della comunità petrina, si attesterebbe ugualmente la convinzione diffusa di una residenza romana dell’Apostolo.
Eccoci, allora, alla terza tappa, quella della connessione del martirio di Pietro con la città di Roma. Certo, gli scritti neotestamentari, che – lo ripetiamo – parlano del martirio e del soggiorno romano di Pietro, non offrono al riguardo indicazioni. Ma non bisogna ignorare l’esistenza di documenti di poco posteriori agli eventi che confermano questo legame. Purtroppo, a causa dei limiti della nostra analisi, non possiamo che essere essenziali. Nella sua Lettera ai Corinzi, scritta verso l’anno 95, papa Clemente I ( lo fu dall’88 al 97), fa un esplicito riferimento al martirio romano delle due «colonne più elevate» della Chiesa (5, 2-3). Siamo a pochi anni dopo i fatti e quindi era facile contestare questo dato che, invece, viene ormai considerato pacifico.
Anzi, un famoso storico della Chiesa del III-IV secolo, Eusebio di Cesarea, nella sua opera Storia ecclesiastica (2, 25, 1-8) cita lo scritto di un prete romano, Gaio, il quale attesta l’esistenza, già nel II secolo, di un “trofeo” nell’area vaticana in memoria della morte di Pietro (così come un altro era stato eretto sulla via Ostiense per Paolo) con l’iscrizione del nome dell’apostolo. Dal 1939 in avanti, attraverso varie prospezioni archeologiche nei sotterranei della Basilica di San Pietro, sono state individuate tracce di questa antichissima memoria, anche attraverso iscrizioni in greco del nome di Pietro e graffiti devozionali con invocazioni all’apostolo. Al di là della conferma, sempre da assumere con molta cautela, offerta dagli scritti apocrifi cristiani (ad esempio, gli Atti di Pietro), rimane quindi un’attestazione – fiorita nei primi decenni della vita della Chiesa, e documentata nell’arco di tempo immediatamente successivo – non solo della presenza di Pietro a Roma ma anche del suo martirio nella stessa città.