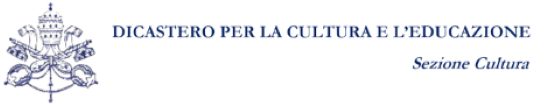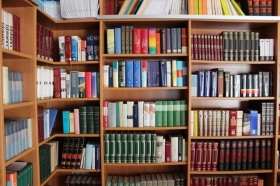Due anni fa l’attuale pontefice ha accettato di interpretare se stesso nel film omonimo Papa Francesco, un uomo di parola, diretto da Wim Wenders, il regista tedesco del Cielo sopra Berlino, mentre lo scorso 7 dicembre, incontrando i gestori delle sale parrocchiali (a cui la settima arte deve tanto per la sua diffusione popolare, come insegna Nuovo Cinema Paradiso di Tornatore), ribadiva l’importanza del cinema come strumento di aggregazione, di comunità e come «grande scuola di umanesimo e di umanità». È curioso osservare che alcuni mesi dopo l’esperimento archetipico dei fratelli Lumière e precisamente il 26 febbraio 1896, un operatore, Vittorio Calcina, proprio su impulso degli stessi fratelli, varcava le soglie del Palazzo Apostolico vaticano con le sue apparecchiature per filmare papa Leone XIII nell’atto di benedire. Poco tempo dopo un collaboratore di Edison, l’inventore della lampada elettrica a filamenti di carbone, riprendeva lo stesso vecchio pontefice mentre passeggiava nei giardini vaticani, a beneficio dei fedeli americani, desiderosi di vedere il papa «di persona».
La Chiesa, di fronte al successivo e ininterrotto fiume di immagini filmiche sacre e blasfeme, pacifiche ed efferate, caste e oscene, non è rimasta solo ai margini come osservatrice, ma è intervenuta a più riprese, anche a livello ufficiale. Così, già nel 1929 Pio XI con l’enciclica Divini illius Magistri riconosceva il valore educativo, divulgativo ed evangelizzatore di questa arte. Fu ancora lui nel 1936 a dedicare al cinema un’intera enciclica, la Vigilanti cura, critica sui rischi ma positiva sull’efficacia e il fascino di tale mezzo di comunicazione. Il suo successore, Pio XII, in due discorsi del 1955 continuava questa riflessione secondo un registro che contemperava riserve e appoggio, per approdare poi all’enciclica Miranda prorsus del 1957 riservata più ampiamente al fenomeno della nuova comunicazione.
Fu così che Giovanni XXIII nel 1959 costituì la Filmoteca Vaticana, uno straordinario deposito documentario di questa disciplina artistica, fatto conoscere con varie iniziative lo scorso anno nella ricorrenza anniversaria della sua istituzione. Con Paolo VI e con la celebrazione annuale della Giornata Mondiale delle comunicazioni sociali, sulla scia del decreto del Concilio Vaticano II Inter mirifica (1963) – che fu significativamente il documento più «contestato» dai Padri conciliari (ebbe 503 voti contrari su poco più di 2000 votanti) – si apriva quella fase che avrebbe avuto il suo apice con Giovanni Paolo II, un papa a forte impatto visivo.
Ed è proprio su questa scia che si può sviluppare un altro discorso parallelo, quello dei Papi di fronte alla telecamera, come recita il titolo di un ampio saggio fittamente documentato, elaborato dalla giornalista Martina Luise, figlia d’arte di Raffaele, uno dei maggiori, più competenti e raffinati vaticanisti radiofonici. Ad avallare questa imponente ricerca sul legame tra i papi e la televisione è lo stesso Segretario di Stato Vaticano, il card. Pietro Parolin, con un’introduzione capace di delineare in modo essenziale la trama di questo nesso, iniziato nella Pasqua del 1949 con Pio XII che si rivolgeva ai telespettatori della TV francese. A ricordare questo evento è stato lo stesso papa Francesco nel messaggio «Urbi et Orbi» della Pasqua dello scorso anno.
Il volume, che avrebbe meritato un indice dei nomi data la folla delle persone che sono coinvolte in queste pagine, prende le mosse appunto da Pio XII, figura ieratica e sacrale, procede con la freschezza spontanea di Giovanni XXIII (chi non ricorda il celebre «discorso della luna» alla sera dell’apertura del Concilio Vaticano II?), si sofferma sullo stile sobrio ma incisivo di Paolo VI del quale rimarranno indimenticabili sia le telecronache dei viaggi, in particolare quello in Terrasanta, sia l’angoscioso appello agli «uomini delle Brigate Rosse» in favore di Aldo Moro. Ma, come si diceva, il lungo pontificato di un papa «televisivo» come Giovanni Paolo II occupa la parte centrale del saggio.
Non è, certo, necessario rievocare le sequenze della sua biografia televisiva nella quale quasi ogni fotogramma ha registrato un impatto pubblico straordinario, e non solo nella tragicità dell’attentato di piazza S. Pietro o nella drammaticità «corporale» degli ultimi tempi della sua vita o nel tormento dell’incomunicabilità fisica che divenne in realtà un’icona televisiva unica per potenza. Ciò che può sorprendere è, invece, il notevole spazio che Martina Luise riserva a Benedetto XVI, a prima vista più refrattario a un mezzo così immediato e di superficie com’è quello televisivo. È, perciò, interessante seguire il racconto che l’autrice fa ovviamente a partire dalla sua proclamazione a pontefice nel 2005 e che approda all’emozionante scena dell’addio dopo la rinuncia, col volo dell’elicottero bianco nel cielo di Roma.
A questo proposito, è interessante quello che ha scritto sul rapporto tra papa Ratzinger e la televisione il principe di tutti i critici televisivi, anche se le sue competenze hanno confini più vasti e si rivelano sempre creative, Aldo Grasso: «Il pontificato di Benedetto XVI è stato meno mediatico del precedente, più incentrato sul valore della parola. E qui si gioca il senso profondo della parola carisma, ai tempi della TV… Il papa del Logos si è congedato con una pagina di grande cinema» (così sul Corriere della Sera del 2 marzo 2019). A questo punto, il discorso va in discesa con papa Francesco, inseguito dalle telecamere fin dal primo affaccio alla loggia di S. Pietro con quel sorprendente «Buonasera» e l’invito rivolto ai fedeli perché facessero scendere su di lui la benedizione divina.
L’analisi della Luise è condotta con uno spoglio accurato del linguaggio di Francesco, della sua capacità simbiotica di interloquire col pubblico ma anche dell’accettazione della provocazione insita a ogni intervista che egli facilmente concede. Ma l’esame si allunga anche ai molteplici approfondimenti condotti sul suo «stare» in televisione, interessandosi anche al muro di ostilità eretto da alcuni media nei suoi confronti. Papa Francesco ha compreso pienamente la metamorfosi subita dalla grammatica comunicativa non solo nell’èra televisiva, ma anche nel tempo dell’infosfera, e quindi dei social. La verifica è condotta sia a livello minimale puntando ad esempio persino al dettaglio delle scarpe nere (d’altronde quelle rosse di Benedetto XVI avevano già avuto la loro «esegesi»), sia sul piano più strutturale della sua comunicazione orale, simbolica, somatica.
Il libro di Martina Luise merita una nota complementare. Il vaglio del dialogo tra pontificato e televisione è indubbiamente il cuore del saggio, ma l’autrice è consapevole della necessità di ricostruire il contesto. Ebbene, in queste pagine sarà possibile ritrovare l’orizzonte storico, culturale e soprattutto ecclesiale entro cui sono collocate le figure dei papi presi in esame. È solo così che acquistano consistenza piena le immagini che i codici televisivi interpretano secondo una loro ermeneutica incisiva ma non esaustiva, spesso decisiva ma non esclusiva.
GIANFRANCO RAVASI
Martina Luise, I papi di fronte alla telecamera. Da Pio XII a papa Francesco, prefazione del card. Pietro Parolin, introduzione di Sergio Zavoli, postfazione di Raniero La Valle, Aracne, Canterano (Roma), pagg. 268, € 15,00.
Si veda anche Dario E. Viganò (a cura di), Telecamere su San Pietro, Vita e Pensiero, Milano 2013.
Pubblicato col titolo: Grandi pontefici a più riprese, su IlSole24ORE n. 53 (23/02/2020).