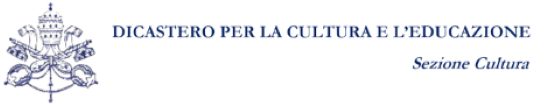«La natura e le sue leggi erano nascoste nella notte. / Dio disse: Sia Newton! E tutto fu illuminato». Era stato dato l’incarico al cattolico Alexander Pope di stendere l’epitaffio per il fieramente protestante Isacco Newton, e il famoso poeta inglese compose il distico citato che però non approdò mai sulla tomba dello scienziato. Effettivamente con Galileo e Newton si compie quella rivoluzione scientifica che ancor oggi marcia spedita verso nuovi orizzonti con passo baldanzoso e talora persino – bisogna riconoscerlo – provocatorio. Con quei due protagonisti la scienza apparentemente si strappava i lacciuoli della filosofia e della teologia, disegnando il proprio statuto epistemologico autonomo. In verità, come è noto, i due grandi artefici di quella rivoluzione erano credenti in senso pieno e profondo. Se Galileo si orientava persino verso dimensioni mistiche e stendeva nelle lettere a Cristina di Lorena e all’abate benedettino Castelli un esemplare progetto di ermeneutica delle Sacre Scritture, Newton si dilettava di esegesi, non esitando a inoltrarsi nella foresta simbolica dell’Apocalisse con un trattatello di forte impronta apologetica anglicana (e quindi “antipapista”).
Era lui nelle Memoirs raccolte da Brewster a proclamare con umiltà il compito dello scienziato con parole che Galileo aveva già prospettato in forma ancor più lapidaria e “teologica”: « Non so che immagine abbia di me il mondo, ma io mi vedo come un bambino che gioca sulla riva del mare e di tanto in tanto si diverte a scoprire un ciottolo più levigato o una conchiglia più bella del consueto, mentre davanti mi si distende, inesplorato, l’immenso oceano della verità». Il “caso Galileo”, ma soprattutto la divaricazione tra scienza e fede nei secoli successivi hanno creato una sostanziale impressione di conflittualità che in questi ultimi tempi è stata ancor più accentuata, rasentando l’insulto, al punto tale che un accademico si sentiva recentemente in dovere di sbeffeggiare i colleghi che ostinatamente perseverano nella fede, considerata come un relitto del paleolitico intellettuale, buttato ai margini del luminoso e progressivo viale percorso dalla scienza. Similmente non mancano in certi ambiti religiosi toni da anatema contro una scienza considerata come avversaria acerrima di ogni fede.
È, perciò, molto interessante prendere tra le mani un volumetto – per altro scritto senza esoterismi disciplinari – allestito da un docente di matematica e fisica che è anche teologo, Simone Morandini, attorno al binomio “teologia e fisica”. In realtà, in questi ultimi anni, non è che i teologi siano rimasti inerti sotto il diluvio di accuse, sopportandole asceticamente: ad esempio un attore importante sulla scena dell’attuale dibattito teologico come Jürgen Moltmann ha pubblicato un saggio su Scienza e Sapienza, sottotitolandolo “Scienza e Teologia in dialogo” (Queriniana 2003), mentre un plotone di studiosi ha elaborato un poderoso Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede (Urbaniana University Press – Città Nuova 2002), e così via con un’ormai fitta bibliografia che Morandini, appunto, elenca. A lui tocca, però, il compito di tirare le fila in modo didattico e sintetico e lo fa sostanzialmente in tre tappe: segnala la novità epistemologica della rivoluzione sopra citata, punta al confronto più novecentesco sul terreno della cosmologia, laddove la teologia ha gettato di nuovo sul piatto della bilancia la questione teleologica, ossia della finalità, e infine procede verso il cuore del duello o del dialogo.
È qui che si aprono nuove prospettive metodologiche, nelle quali i molteplici approcci e gli stessi linguaggi tentano di comporsi in coesistenza senza esplodere in reciproci rigetti o ribrezzi, pur conservando la coerenza specifica di ciascuno di essi nel “custodire costantemente la propria frontiera”, come suggeriva il filosofo Schelling. Il lettore profano (sia nel campo della fisica sia della teologia) scoprirà in queste pagine percorsi suggestivi e forse deporrà i vari armamentari o armature che lo condizionano: quelli “concordistici”, sbrigativi e fragili, o quelli radicali che rivendicano autosufficienza ed esaustività solo per uno dei due campi. Per certi versi si ripropone il superamento di quel bipolarismo tra sincretismo e fondamentalismo che oscura lo spettro cromatico variegato di ogni confronto tra sapere religioso e conoscenza profana.
Certo, il testo di Morandini – soprattutto nella terza parte – può sollevare qualche perplessità, anche per l’ardore dell’intento spirituale e testimoniale dispiegato, ma riteniamo che la proposta di confronto tra teologia e fisica (si noti che il campo è ristretto al solo orizzonte della fisica; altri ambiti ancor più scottanti come quelli della biologia esigerebbero una trattazione parallela), che ci viene qui dispiegata, meriti attenzione pacata e serena. Sì, perché se è molto positivo che la scienza scenda nell’agorà pubblica occupando pagine e pagine di giornali, è altrettanto vero che essa, come la teologia, ha bisogno di rigore, pacatezza e accuratezza. Certo, non è il massimo del correct, ma non aveva tutti i torti Cartesio quando nelle sue Meditazioni annotava: «La scienza è come una donna: se rimane pudica, presso suo marito, è onorata; se diventa troppo pubblica, si avvilisce». E questo vale anche per la teologia.
Simone Morandini, «Teologia e fisica», Morcelliana, Brescia, pagg. 228.